COVID 19 - Le trasformazioni del mondo del lavoro e l’impatto sociale di esse
- Lega Consumatori ER
- 23 set 2021
- Tempo di lettura: 10 min
Aggiornamento: 6 ott 2021
(di Chiara Pazzaglia)
Il mondo del lavoro, in Italia, ha subito profonde trasformazioni recenti. Senza guardare indietro di 50 anni, alla legge 300/1970 (il famoso “statuto dei lavoratori”), è sufficiente pensare all’ultimo ventennio. Questo non è cominciato bene: nel 1999 ci fu l’omicidio di Massimo D’Antona, nel 2002 quello di Marco Biagi, che ha segnato profondamente Bologna e riportato il massimo livello di attenzione nei confronti delle Nuove Brigate Rosse. L’oggetto della violenta contestazione erano, soprattutto, quelle riforme percepite da questi estremisti come “precarizzanti”. In realtà, si trattava di togliere determinati privilegi ad alcune categorie di lavoratori, per estendere maggiori diritti a tutti gli altri. Negli Stati Uniti, ma anche nel resto d’Europa, si stavano già sperimentando nuove forme di flessibilità, ben più adeguate alle trasformazioni in corso. Questi cambiamenti erano, anzitutto, sociali ed economici: già dagli anni Novanta la globalizzazione stava divenendo una realtà. Per stare al passo col resto del mondo, era necessario che anche il nostro Paese si adeguasse. Ma mentre negli USA la flessibilità è (tuttora) un punto di forza anche per il lavoratore stesso, che può facilmente passare da un posto all’altro senza lunghi periodi di disoccupazione, il Italia non eravamo e forse non siamo ancora pronti. Marco Biagi non fece in tempo a vedere applicate quelle clausole di salvaguardia che aveva previsto nel suo “libro bianco”. Ecco perché la “legge Biagi” meriterebbe forse un altro nome. La Legge 30, preferiamo chiamarla così, entrata in vigore un anno dopo il barbaro omicidio del giuslavorista, contiene alcune novità allora rivoluzionarie, oggi ben consolidate nel mercato del lavoro. Con il senno di poi, non è facile fare delle valutazioni. Se è vero che le donne e i giovani, in particolare, sono divenuti più “precari” sul lavoro, è anche vero che le trasformazioni in corso avrebbero, probabilmente, fatto perdere del tutto il lavoro a queste categorie. Come ha più volte fatto rilevare Michele Tiraboschi, ordinario di Diritto del Lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia ed “erede” della cattedra di Biagi, negli anni seguenti il tasso di occupazione è aumentato progressivamente. Questo, probabilmente, è accaduto un po’ per effetto delle regolarizzazioni, un po’ perché la flessibilità consentiva e consente di far fronte, in maniera lecita, ai picchi di lavoro e alle oscillazioni del mercato, impiegando persone che, comunque, in condizioni diverse forse non avrebbero trovato collocazione.
La gig-economy e le necessarie tutele dei lavoratori digitali
Col tempo, il mondo de lavoro ha affrontato molte altre crisi e cambiamenti. Avvicinandoci ai giorni nostri, pensiamo alla rivoluzione portata dalla gig-economy. Essa impiega, ad oggi, più di 5 milioni di lavoratori. L’avvento di internet non ha cambiato solo il nostro modo di interagire, ma anche quello di lavorare. Questi professionisti non sono dipendenti: non hanno orari fissi, né scrivania. Vanno dai famosi “riders”, fino agli informatici delle più raffinate industrie del digitale: ciò avviene in California, dove la gig-economy è nata e dove, dal 2019, è normata e regolamentata al pari del lavoro dipendente. La definizione si è diffusa grazie ad Hilary Clinton, che la utilizzò nel 2015 durante un discorso della sua campagna elettorale. Ma è riduttivo pensarla come l’“economia delle piattaforme”. Infatti, non siamo dinnanzi a modelli di business omogenei, anzi, spesso presentano profonde differenze: diversi metodi di assegnazione del lavoro e di pagamento, utilizzo di piattaforme specialistiche o generaliste, un diverso grado di complessità del lavoro richiesto e di controllo sulla prestazione. La maggior parte delle piattaforme organizza i turni e assegna mansioni ai lavoratori sulla base di algoritmi. Di fronte a ciò, dobbiamo anzitutto sfatare il mito della “neutralità dei numeri”: i sistemi algoritmici sono prodotti storici e sociali che riflettono le scelte e gli assunti culturali di esseri umani e organizzazioni. I social, le pubblicità che essi ci propongono, ci conoscono ormai meglio di noi stessi, tanto da arrivare ad anticipare i nostri desideri. Li condizionano, anche? Difficile a dirsi. È più probabile che li prevengano, mostrandoci per lo più pubblicità di oggetti a noi graditi, sulla base delle nostre ricerche online e delle preferenze espresse nel web. Tuttavia, è difficile negare che, sul lungo periodo, influenzino le nostre decisioni. Avviene lo stesso nelle piattaforme: ogni feedback ed ogni valutazione che il lavoratore riceve influisce sulle sue possibilità di lavorare, addirittura sul salario. Ad esempio, ad oggi, nessuno è riuscito a svelare i complessi meccanismi valutativi che regolano l’algoritmo della piattaforma di food delivery chiamata Deliveroo. Nel 2020, il sindacato Ugl e AssoDelivery (l’associazione che rappresenta le piattaforme digitali della consegna del cibo a domicilio Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats) hanno firmato un documento che definiscono un “contratto collettivo nazionale di lavoro”. Il testo prevede, tra l’altro, un compenso minimo pari a 10 euro in base al tempo per svolgere ogni consegna; un incentivo orario di 7 euro, anche nel caso di assenza di proposte di lavoro, per i primi 4 mesi dall'apertura del servizio presso una nuova città; un sistema premiale pari a 600 euro ogni 2 mila consegne ed altro. Bologna è stata protagonista delle trattative, essendo stata lo scenario delle prime proteste e scioperi dei riders ed avendo precorso i tempi stilando l’omonima “carta”, presa poi a modello nazionale: una sorta di codice etico delle consegne a domicilio. Sebbene Deliveroo, dunque, preveda un salario minimo di 11 € lordi all’ora, nei fatti paga solo i minuti che ritiene necessari a pedalare dal ristorante alla porta di casa del cliente: non importa se il tempo effettivo è maggiore, perché il rider deve attendere che il cibo sia pronto, perché c’è traffico o perché il cliente non è sollecito ad aprire. Il rider si trova comunque nella condizione di non poter rifiutare l’ingaggio: infatti, il famigerato algoritmo lo penalizzerebbe per il futuro. La penale ricade sul lavoratore a cottimo anche di fronte ad ogni sorta di imprevisto: dal foro di una ruota all’errore del ristoratore. L’algoritmo che calcola le tariffe è ben integrato con tutte le altre parti del sistema. All’inizio, la modalità di prenotazione dava la possibilità di accaparrarsi più ore di lavoro settimanali a chi copriva anche i turni del fine settimana. In seguito a una sentenza, questo sistema è stato eliminato: tutti i rider possono loggarsi all’app in qualsiasi momento senza prenotazione. Ecco che, di nuovo, l’incentivo a lavorare nel weekend è lasciato alle differenze tariffarie. Fu addirittura un giudice, proprio bolognese, che nella prima causa nazionale di riders contro Deliveroo chiese all’azienda di spiegare il funzionamento dei suoi algoritmi: questa si rifiutò. Oggi, la trasparenza è sempre più invocata, ma la ricchezza dei colossi della gig-economy risiede proprio nell’immaterialità di queste intelligenze artificiali, dunque è difficile pensare che possano rivelare i loro segreti. L’Università di Bologna ha di recente ingaggiato il filosofo oxoniense Luciano Floridi, che insegnerà agli ingegneri come il loro lavoro debba essere strettamente connesso all’etica. Questo, oggi, vale per la tecnica, la tecnologia, la medicina: siamo sollecitati sempre di più a interrogarci sulle conseguenze del progresso e, dunque, delle nostre mansioni professionali.
Le conseguenze della pandemia sul mondo del lavoro
La pandemia ha costituito un altro scossone importante nel mondo del lavoro. Tutti ricordiamo bene di essere stati costretti al lavoro da remoto per lungo tempo e questo ha accelerato molti processi tecnologici, ma anche sociali. Dal marzo del 2020 l’home working è entrato a far parte delle nostre vite e delle nostre carriere. Ma se, solo fino a due anni fa, lo Smart working era il sogno di molti, soprattutto di molte mamme lavoratrici, per aziende e lavoratori esso si è tramutato in un disagio. Era infatti concepito come misura di conciliazione dei tempi vita-lavoro, consentendo di risparmiare tempo e costi di viaggio e di organizzare meglio le esigenze familiari, rispetto a quelle professionali. Ma il vero Smart working richiede un’organizzazione che non si improvvisa. Occorrono strumenti adeguati, hardware e software, ma è necessario anche che la comunicazione interna e la gestione dei documenti abbiano un ottimo livello di digitalizzazione, così come è indispensabile che i ruoli aziendali siano ben definiti e che il management sia in grado di gestire la leadership sia in presenza, sia a distanza. La pandemia ha accelerato un processo che, per molti, era senza dubbio già in corso. Tuttavia, altri si sono trovati impreparati. Oggi, difficilmente possiamo pensare di tornare indietro nel tempo e di riscoprirci gli stessi lavoratori di due anni fa. Anzi, le riunioni di lavoro in presenza, magari in un’altra città, sono ormai percepite come un peso e come una perdita di tempo da evitare. Tuttavia, sono emersi diversi effetti collaterali, in questa corsa allo Smart working. Prima di tutto, molte aziende arrancano nella digitalizzazione dei processi: quelle più tradizionali, ancorate a sistemi di lavoro classici, hanno fatto di tutto per riportare in presenza la forza lavoro. Ora si trovano combattute nel comprendere se questo le penalizzi nei confronti della concorrenza più organizzata o se, al contrario, possa essere un punto di forza. Infatti, il lavoro da remoto richiede di investire in tecnologia, ma, d’altra parte, consente di risparmiare sui benefit aziendali (ad esempio i buoni pasto), sui i costi di trasferta, in casi estremi anche sull’affitto di spazi, pulizie e utenze di essi. È presto per dire se andremo verso un “lavoro da ogni dove” sempre più diffuso: ciò che è più probabile è che adotteremo un sistema ibrido, in cui non sarà più considerata fondamentale la presenza fisica in ufficio, se non di tanto in tanto. Ciò dovrebbe favorire l’occupazione femminile. Pensiamo a quelle serie TV americane, ambientate nei grossi, competitivi studi di avvocati d’Oltreoceano: la prima cosa che salta all’occhio è che, spesso, i protagonisti che hanno famiglia e non possono protrarre l’orario d’ufficio, anche per 12 ore al giorno, come richiesto, sono penalizzati nella carriera. La presenza fisica fino a tarda ora è ancora sovente determinante agli occhi dei superiori, per esprimere l’attaccamento al lavoro. Ecco, la pandemia ha avviato una piccola rivoluzione a favore di chi privilegia il criterio del raggiungimento di obiettivi, rispetto al tempo impiegato per farlo. La misura della produttività è sempre più spesso oggetto di merito, che prevale sulla durata della prestazione. Le donne sono statisticamente più produttive sul lavoro: sanno di dovere ottimizzare il tempo, per dedicarsi alla cura familiare. L’ISTAT segnala che il 98% di posti di lavoro persi durante la pandemia sono di donne, che si sono dovute barcamenare con la DAD dei figli e la cura dei genitori: la prospettiva sembra, però, favorirle, se saremo così lungimiranti da apprendere da ciò che ci è successo. Il rapporto Eurispes di maggio 2021 segnala che su 444.000 posti di lavoro persi, sono 312.000 quelli femminili. La cifra è spaventosa. Secondo Eurispes, il divario tra il tasso di occupazione femminile e maschile continua ad essere tra i più alti in Europa e il Global Gender Gap Report 2020 riporta che l’Italia è solo 76esima nella classifica mondiale sulla parità salariale (ha perso 6 posizioni rispetto al 2019). Il reddito mensile medio delle donne in Italia è inferiore del 18% rispetto a quello maschile; il divario sale al 30% nelle coppie con figli (Eige, European Institute for gender Equality). Questa disparità è tanto più assurda se si considera che le donne hanno un livello medio di istruzione più alto e migliori risultati scolastici. I motivi sono da rintracciare soprattutto nel fatto che le lavoratrici si trovano più spesso in una posizione debole, con contratti meno stabili, part-time, in settori che non consentono il lavoro a distanza. Eppure, per l’economia globale il lavoro femminile è fondamentale. La cosiddetta Womenomics, neologismo coniato da The Economist nel 2006 (riprendendo le tesi di una analista di Goldman Sachs del 1999), definisce la teoria economica secondo la quale il lavoro delle donne è oggi il più importante motore dello sviluppo mondiale.
Il lavoro come dignità dell’uomo e della donna
Mentre scriviamo, la nostra Regione sta vivendo gravi turbamenti nel mondo delle imprese. Pensiamo che, nel 2017, quando Papa Francesco venne a Bologna elogiò il cosiddetto “sistema Emilia”, che comprende quelle misure per l’occupazione quali il Patto per il lavoro, siglato tra Istituzioni e parti sociali, che oggi è diventato un “Patto per il lavoro e per il clima”. La stessa Diocesi, proprietaria di un’azienda importante, la FAAC, insieme alla Città Metropolitana ha investito diversi milioni di euro nel progetto “Insieme per il lavoro”, una “buona pratica occupazionale” che è guardata con interesse da tanti altri territori, sebbene mostri alcune lacune e alcune difficoltà nel trovare figure professionali aderenti ai desiderata delle aziende. L’Emilia-Romagna è anche terra d’elezione del sistema cooperativo, che molto ha a che fare con l’etica del lavoro e la dignità della persona. Eppure, sebbene persino nel PNRR il nostro sistema di formazione professionale sia citato come esempio virtuoso, ancora fatichiamo a formare figure che siano utili alle aziende. Il motivo, probabilmente, è da ricercare nella ancora lacunosa collaborazione tra scuola, imprese, università, formazione professionale ed amministrazioni locali. Al contempo, è necessario garantire ai lavoratori contratti più stabili, con retribuzioni dignitose. I cosiddetti “working poors” sono ormai una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Eppure, sappiamo bene che il lavoro, per l’uomo, deve essere prima di tutto fonte di dignità e realizzazione personale e familiare. In 5 anni i tavoli di crisi aperti in Città Metropolitana sono quintuplicati: a volte si tratta di poche decine di dipendenti, altre volte di qualche centinaio, ma l’elemento più preoccupante riguarda il fatto che, un tempo, le crisi aziendali derivavano da cali produttivi e conti in rosso. Oggi, invece, raramente siamo di fronte a fallimenti: si tratta per lo più di multinazionali, spesso controllate da fondi speculativi, che delocalizzano la produzione per massimizzare i profitti e distribuire gli utili agli investitori. L’ultimo caso è quello di Logista, che ha di fatto licenziato oltre 60 dipendenti con un messaggio inviato su Whatsapp: “lunedì non devi presentarti al lavoro”. Ecco, questa disumanizzazione ci interpella tutti: le grosse aziende, infatti, sono sempre più spesso controllate da fondi in cui le banche investono i nostri modesti risparmi, quando vengono loro affidati. Non bastano più le ottime esperienze in circolazione di “finanza etica”, perché restano una nicchia per pochi, per persone già sensibilizzate al tema. Tutto il sistema economico dovrebbe diventare etico, “win-win”, in cui, cioè, il benessere dell’uno ricade su tutto il tessuto sociale circostante. Il welfare aziendale stesso ha sempre maggiori ricadute non solo sui dipendenti, ma anche sul territorio in cui vivono. Questo ci esorta a costruire un sistema sociale in cui anche le imprese devono essere parte in causa del benessere collettivo. Ormai, non abbiamo più veri imprenditori: abbiamo startupper, che inseguono l’affare, che creano business per rivendere l’idea; abbiamo CEO che agiscono per conto di fondi di investimento, i quali puntano solo al profitto ad ogni costo, anche nel caso di siti produttivi che funzionano benissimo. L’economia è sempre più immateriale, svincolata dai processi produttivi, ma questo porta ad una disumanizzazione del lavoro che non si concilia più con la realizzazione dell’uomo. È compito della politica, delle parti sociali, dei corpi intermedi cercare di arginare questa logica del business, puntando su valori condivisi e cercando di offrire qualcosa che nessun fondo può comprare, ovvero il benessere sociale. Dipendenti felici e realizzati lavorano meglio: dovrebbe diventare un assunto fondamentale, mentre ancora oggi ciò si verifica solo in esperienze di nicchia (che, fortunatamente, esistono e, temerariamente, resistono). A fine ottobre arriveremo al temuto sblocco dei licenziamenti e dobbiamo guardare a questo momento con timore, ma anche come l’occasione di puntare ad un rinnovamento del mondo del lavoro, in cui l’uomo non competa con l’algoritmo, ma lo governi. Un mondo del lavoro più umanizzato, in cui la massimizzazione del profitto passi da investimenti sul territorio, che garantiscano un benessere collettivo: conviene anche alle imprese.
Bologna, agosto 2021
REALIZZATO CON FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. RIPARTO 2020

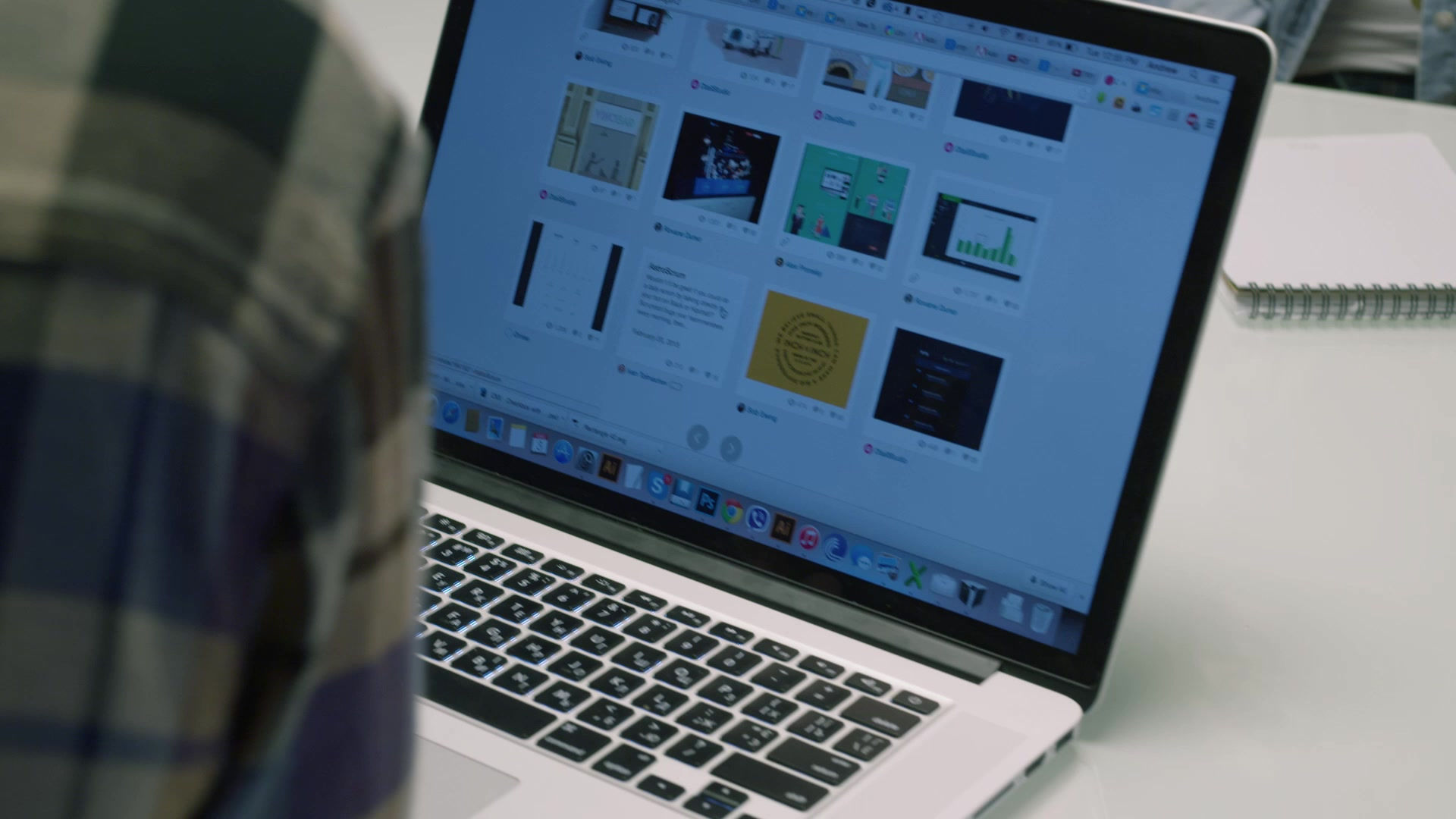


Commenti